
Terapista accademico del linguaggio (Patolinguistica B.Sc.) e linguista. Lavora con pazienti in età evolutiva e adulta, con un particolare focus nei disturbi della fluenza, il mutismo selettivo e l’autismo. Realizzatore, insieme alla collega Carolina Zanchi, del podcast LingoScienceIT - Logopedia basata sull’evidenza.
La balbuzie è un disturbo multidimensionale della fluenza verbale, con una prevalenza stimata dello 0.72% nella popolazione adulta [1]. È caratterizzata da comportamenti primari o overt (blocchi, ripetizioni e prolungamenti), comportamenti secondari (come la tensione facciale) e aspetti nascosti o covert (come sentimenti negativi ed ansia sociale) [2].
Come ha mostrato la ricerca nel corso degli anni, la balbuzie può avere un impatto negativo sulla vita della persona che balbetta (PWS) al di là della comunicazione, con conseguenze sulla salute mentale [3, 4, 5] e sulla qualità di vita complessiva [3, 6]. Inoltre, è noto da tempo l’impatto della balbuzie sulla vita lavorativa e sullo stato finanziario delle PWS [7, 8].
La natura multidimensionale della balbuzie si riflette anche nei molteplici approcci terapeutici disponibili [9]. Mentre molti approcci si concentrano principalmente sulla fluenza verbale [10], gli approcci multidimensionali mirano a ridurre le conseguenze negative della balbuzie, lavorando contemporaneamente sulla fluenza verbale [11,12].
Studi recenti hanno mostrato l’efficacia delle terapie psicologiche generali per il trattamento della balbuzie, tra cui la Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) [13,14] e la Acceptance and Commitment Therapy (ACT) [15], con miglioramenti sia nel funzionamento psicosociale che nella fluenza verbale. La considerazione delle caratteristiche covert, come pensieri, sentimenti e reazioni della PWS alla balbuzie, sebbene spesso trascurate nel trattamento, può migliorare i risultati dell’intervento [16,17]. Pertanto, nella scelta di un approccio terapeutico specifico per PWS, è stata raccomandata l’adozione di una prospettiva multifattoriale [18, 19].
Indipendentemente dal tipo di trattamento, la terapia della balbuzie è nota per gli alti tassi di ricaduta [16]. Tuttavia, sono stati riscontrati livelli più elevati di ricaduta dopo interventi che si concentrano principalmente sul mantenimento della fluenza verbale rispetto a quelli che prevedono la modificazione della balbuzie (imparare a balbettare con meno tensione fisica) e la riduzione dell’ansia comunicativa associata alla balbuzie [16].
Una maggiore comprensione del vissuto delle PWS può dunque contribuire al ragionamento clinico e al processo decisionale per quanto riguarda gli approcci al trattamento della balbuzie. In questo contesto, i metodi di ricerca qualitativa possono facilitare una maggiore conoscenza e comprensione della balbuzie e dell’impatto che essa ha sulla vita di un individuo [20, 21, 22]. In questo modo sarà anche possibile sviluppare programmi di trattamento migliori, fornendo un trattamento olistico più mirato e migliorando i risultati del trattamento e la soddisfazione delle PWS.
Connery, McCurtin e Robinson [23] hanno condotto una revisione sistematica della letteratura, con lo scopo di identificare e sintetizzare la ricerca qualitativa sulle esperienze vissute dagli adulti che balbettano, attraverso il processo della meta-etnografia. La meta-etnografia è un metodo utilizzato in ambito sanitario per la ricerca relativa alle esperienze di malattia e assistenza dei pazienti [24]. Essa consente una sintesi rigorosa della ricerca qualitativa e può potenzialmente fornire un livello di analisi più elevato interpretando i risultati degli studi inclusi [24].
La ricerca è stata condotta su sette diversi database, seguendo le linee guida PRISMA nel riportare la ricerca per revisioni sistematiche e meta-analisi [25]. Sono stati inclusi studi qualitativi pubblicati dal 2000 al 2018 in lingua inglese che avevano come oggetto il vissuto delle PWS adulte. In totale sono stati inclusi nella revisione diciassette studi [16, 26-41]. Dal processo di sintesi sono emersi cinque temi che descrivono l’esperienza vissuta degli adulti che balbettano.
L’uso dell’evitamento per gestire la balbuzie è emerso come tema centrale, essendo descritto in undici studi [16, 27-32, 38-41] ed è stato il tema più diffuso in relazione all’esperienza della balbuzie.
L’evitamento ha assunto diverse forme, in particolare l’evitamento di determinate parole [27, 29-32, 38], delle situazioni sociali [16, 27, 30, 32, 39] e persino delle interazioni sanitarie a causa del disagio cronico nel parlare [39].
Una partecipante, ad esempio, ha descritto l’entità del comportamento di evitamento parlando del suo rapporto con il medico di base: “Non ci vado a meno che non sia necessario, a meno che non sia una questione di vita o di morte… perché non voglio parlare e spiegare nei minimi dettagli cosa sta succedendo” [39, p.1641].
Anche l’evitamento specifico delle conversazioni telefoniche è stato evidenziato come particolarmente problematico in tre studi [28, 31, 39], con la paura come emozione principale associata a tali interazioni.
In due studi, i partecipanti hanno inoltre identificato l’evitamento come una strategia di coping inefficace piuttosto che efficace per la gestione della balbuzie [40, 41].
Come ha sostenuto un partecipante, “…ho dedicato più energie a evitare le situazioni che a impegnarmi in una comunicazione di qualsiasi tipo” [41, p.64].
L’impatto occupazionale della balbuzie è stato descritto dai partecipanti in nove studi [26, 28-33, 35, 38].
I partecipanti a questi studi hanno percepito che la balbuzie ha influenzato negativamente le loro carriere in vari modi, tra cui la scelta del tipo di lavoro [32, 33] con il risultato che diversi partecipanti si sono dimostrati insoddisfatti della loro situazione lavorativa [31].
Un partecipante, ad esempio, ha dichiarato: “Sono andato ad un colloquio…e la persona che mi ha intervistato mi ha detto: ‘Non credo che siamo interessati a lei perché balbetta’”’ [31, p.339]. Sono state evidenziate anche ulteriori difficoltà sul posto di lavoro: la balbuzie ha avuto un impatto sulle relazioni con i superiori e i colleghi e sull’avanzamento di carriera e sulla promozione [26, 29, 30, 38].
A questo proposito, un partecipante ha dichiarato: “Lei (il mio capo) non mi avrebbe promosso perché pensava che non fossi abbastanza bravo – mi ha dato questa impressione a causa della balbuzie” [38, p.289].
Come per il primo tema, la paura legata alla balbuzie è stata evidenziata come impattante sull’avanzamento di carriera, con la paura dei colloqui e delle maggiori richieste verbali associate alla promozione che hanno portato a una riluttanza a candidarsi per tali promozioni [29].
Va però sottolineato che un certo numero di partecipanti non credeva che la balbuzie avesse un impatto sulla vita lavorativa, come la scelta della carriera [29, 33, 38] e la progressione di carriera [38].
Questo tema è stato affrontato in otto studi [16, 30, 32, 34-38] e si riferisce all’impatto che la balbuzie ha sullo sviluppo dell’identità positiva e negativa di un individuo nel corso della vita e alle implicazioni dell’identificazione come adulto che balbetta.
Lo sviluppo di un’identità positiva di sé è stato associato a eventi positivi come l’inclusione, il raggiungimento dei propri obiettivi e il sostegno dell’ambiente in cui vivono le PWS [36].
I partecipanti ad alcuni studi [30, 32] hanno descritto come la balbuzie abbia avuto un impatto negativo sulla loro identità personale, come ha affermato un partecipante, riflettendo su una vita senza difficoltà di comunicazione: “Penso che probabilmente sarei stato più estroverso, più loquace, avrei partecipato molto di più, avrei avuto più alterchi verbali [ride]. Penso che la mia vita sarebbe stata diversa, davvero.” [32, p. 207].
Inoltre, per i partecipanti a uno studio, le ripetute reazioni negative della società e l’autogiudizio critico suggeriscono che l’identità negativa di sé è stata rafforzata nel tempo [35].
La difficoltà ad accettare la propria identità di persona che balbetta è stata espressa con odio e disprezzo verso la balbuzie [30] e alcuni partecipanti hanno dichiarato che la balbuzie li ha fatto sentire “diversi” e “stupidi” [38].
Alcuni partecipanti hanno inoltre fatto una distinzione tra il sé in quanto persona che balbetta e il loro “altro” sé [30].
Questo tema è stato affrontato in sette studi [16, 27-30, 38, 40] e si riferisce all’esperienza e all’aspettativa dell’individuo circa le reazioni negative degli altri alla balbuzie.
La questione dello stigma in relazione alla balbuzie è stata discussa esplicitamente in tre studi [16, 28, 29]. Le reazioni degli ascoltatori comprendono reazioni emotive, comportamentali e cognitive, sia reali che percepite, che hanno portato le PWS a sentirsi stigmatizzate.
I partecipanti agli studi hanno discusso le reazioni emotive avverse degli ascoltatori, tra cui shock, nervosismo, imbarazzo, mancanza di pazienza e di comprensione [16, 38].
Questo ultimo aspetto è stato evidenziato da un partecipante, che ha dichiarato: “Ci sono così tante persone che non capiscono, che dicono: ‘Che cos’è?’ e ti prendono in giro” [16, p.20]. Due studi hanno evidenziato l’insoddisfazione delle PWS per il comportamento degli ascoltatori che terminano le loro frasi [28, 38].
Come ha affermato un partecipante: “Se il pubblico vede un uomo o una donna che fatica a dire le parole, spesso le dice al posto suo, pensando di aiutarli, ma non è così” [28, p.26].
Questo comportamento può essere spiegato dalle percezioni dei partecipanti a due studi [28, 29], secondo cui gli ascoltatori considerano le persone che balbettano meno intelligenti o psicologicamente indisposte.
In diversi studi, i partecipanti hanno discusso l’impatto negativo della balbuzie sullo sviluppo e sul mantenimento di una vasta gamma di relazioni interpersonali, comprese quelle con genitori, fratelli/sorelle e partner [26, 27, 32, 38, 39].
È stata inoltre discussa la formazione di nuove amicizie, con emozioni associate quali timidezza, confusione e paura [26, 38].
Gli impatti positivi e negativi della balbuzie sulle relazioni con i genitori [38] sono stati descritti con comportamenti quali impazienza, mancanza di comprensione e completamento delle frasi dei figli che balbettano da parte dei genitori.
I partecipanti hanno percepito che la balbuzie era emotivamente dolorosa per i genitori: “I miei genitori erano molto feriti e tristi perché era una sorpresa” [38, p.293].
I partecipanti hanno anche discusso l’impatto positivo e negativo della balbuzie sulle relazioni con i loro partner o coniugi [26, 27, 38], evidenziando sia gli effetti negativi (come frustrazione) [38] sia quelli positivi (come sostegno e comprensione) [27, 38].
Un partecipante, parlando della moglie, ha dichiarato: “Lei è stata la mia voce prima [della terapia], per molto tempo” [27, p. 23].
I risultati di questa sintesi mostrano che la balbuzie può potenzialmente avere un impatto significativo e dannoso su molti aspetti della vita di un individuo con conseguenti conseguenze sul benessere.
Questi risultati qualitativi sono inoltre in linea con altrettanti risultati di studi quantitativi condotti con PWS, tra cui gli elevati livelli di ansia sociale e la paura di una valutazione negativa che portano a evitare le situazioni sociali [4, 5, 42], e l’impatto della balbuzie sull’occupazione [7], sulla formazione dell’identità [43] e sullo sviluppo delle relazioni interpersonali [44].
Connery e colleghi [23] sostengono dunque che i terapeuti che lavorano con le PWS dovrebbero lavorare in modo centrato sulla persona per identificare l’impatto della balbuzie sulla vita dei loro pazienti, essendo consapevoli che molte PWS riportano esperienze di vita negative.
Nella scelta di un intervento ottimale, i terapeuti dovrebbero dunque considerare obiettivi olistici e programmi di trattamento che si concentrino sia sulle caratteristiche overt, sia sul vissuto legato alla balbuzie [23].
Per fare questo, la terapia della balbuzie dovrebbe integrare componenti psicologiche per migliorare i risultati del trattamento. Per esempio, approcci terapeutici come la CBT [13, 14] e la ACT [15] possono essere appropriati quando si lavora con adulti in cui i pensieri disadattivi contribuiscono alle difficoltà emotive e ai comportamenti problematici.
Poiché l’evitamento è emerso come tema centrale, gli obiettivi terapeutici che mirano alla riduzione dei comportamenti di evitamento dovrebbero essere una componente centrale di qualsiasi intervento [23].
Approcci terapeutici come la avoidance-reduction therapy (terapia di riduzione dell’evitamento) per la balbuzie [45] possono essere utili per raggiungere tali obiettivi.
Gli approcci psicologici per la gestione dell’evitamento possono avere rilevanza anche per sostenere le PWS nelle sfide della vita lavorativa e nella formazione di un’identità positiva di sé.
Inoltre, gli obiettivi del trattamento che si concentrano sull’aumento del supporto tra pari, ad esempio attraverso i gruppi di auto-aiuto, possono essere utili, visti i benefici della partecipazione ai gruppi di supporto per le persone che balbettano, tra cui la riduzione dello stigma interiorizzato e il miglioramento del benessere psicologico [17, 46].
Lo stigma sociale e le reazioni negative da parte degli altri sono stati un ultimo tema evidenziato da questa sintesi.
L’incorporazione di obiettivi che mirano a una maggiore consapevolezza della condizione da parte del pubblico nell’ambiente immediato e in quello più ampio dell’individuo può essere di beneficio per questo ultimo aspetto [23].
Tali obiettivi migliorerebbero la comprensione da parte del pubblico della balbuzie non solo come disturbo della comunicazione, ma anche come costrutto sociale e faciliterebbero la riduzione delle barriere attitudinali che limitano l’inclusione e la partecipazione delle PWS.
Infine, i risultati di questa sintesi possono trovare ulteriore applicazione nella terapia con bambini e adolescenti che balbettano. Siccome molte difficoltà associate alla balbuzie in età adulta emergono nell’infanzia, se si interviene sugli elementi identificati dell’esperienza vissuta della balbuzie in età precoce, si può ridurre la prevalenza e la gravità della balbuzie in età adulta e migliorare l’esperienza vissuta delle persone che balbettano [23].
Pertanto, i clinici che lavorano con la popolazione pediatrica dovrebbero essere consapevoli degli impatti a lungo termine della balbuzie e incorporare obiettivi incentrati sulla riduzione dell’evitamento, sulla promozione di un’identità positiva di sé, sulla gestione delle reazioni negative degli altri, sullo sviluppo e sul mantenimento delle relazioni (in particolare con i genitori) e sulla preparazione per le future sfide della vita lavorativa [23].
[1] Craig, A., Hancock, K., Tran, Y., Craig, M., & Peters, K. (2002). Epidemiology of stuttering in the community across the entire life span. Journal of Speech, Language and Hearing Research. 2002(45): 1097–1105.
[2] Guitar, B. (2014). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
[3] Craig, A., Blumgart, E., & Tran, Y. (2009). The impact of stuttering on the quality of life in adults who stutter. Journal of fluency disorders, 34(2), 61-71.
[4] Craig, A., & Tran, Y. (2014). Trait and social anxiety in adults with chronic stuttering: Conclusions following meta-analysis. Journal of fluency disorders, 40, 35-43.
[5] Iverach, L., O’Brian, S., Jones, M., Block, S., Lincoln, M., Harrison, E., … & Onslow, M. (2009). Prevalence of anxiety disorders among adults seeking speech therapy for stuttering. Journal of anxiety disorders, 23(7), 928-934.
[6] Koedoot, C., Bouwmans, C., Franken, M. C., & Stolk, E. (2011). Quality of life in adults who stutter. Journal of communication disorders, 44(4), 429-443.
[7] Klein, J. F., & Hood, S. B. (2004). The impact of stuttering on employment opportunities and job performance. Journal of fluency disorders, 29(4), 255-273.
[8] Blumgart, E., Tran, Y., & Craig, A. (2010). An investigation into the personal financial costs associated with stuttering. Journal of Fluency Disorders, 35(3), 203-215.
[9] Yaruss, J. S. (2010). Assessing quality of life in stuttering treatment outcomes research. Journal of fluency disorders, 35(3), 190-202.
[10] Onslow, M., Costa, L., Andrews, C., Harrison, E., & Packman, A. (1996). Speech outcomes of a prolonged-speech treatment for stuttering. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 39(4), 734-749.
[11] Kroll, R., Scott-Sulsky, L. (2010). The fluency plus program: an integration of fluency shaping and cognitive restructuring procedures for adolescents and adults who stutter. In: Guitar, B., McCauley, R. (Ed.) Treatment of stuttering: established and emerging interventions (pp. 277–31). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
[12] Montgomery, CS. (2006). The treatment of stuttering: from the hub to the spoke. In: Bernstein Ratner, N., Tetnowski, JA. (Ed.) Current issues in stuttering research and practice (pp. 159-204). Mahway (NJ): Lawrence Erlbaum.
[13] Helgadóttir, F. D., Menzies, R. G., Onslow, M., Packman, A., & O’Brian, S. (2009). Online CBT II: A Phase I trial of a standalone, online CBT treatment program for social anxiety in stuttering. Behaviour Change, 26(4), 254-270.
[14] Menzies, R. G., Onslow, M., Packman, A., & O’Brian, S. (2009). Cognitive behavior therapy for adults who stutter: A tutorial for speech-language pathologists. Journal of fluency disorders, 34(3), 187-200.
[15] Beilby, J. M., Byrnes, M. L., & Yaruss, J. S. (2012). Acceptance and commitment therapy for adults who stutter: Psychosocial adjustment and speech fluency. Journal of fluency disorders, 37(4), 289-299.
[16] Carter, A., Breen, L., Yaruss, J. S., & Beilby, J. (2017). Self-efficacy and quality of life in adults who stutter. Journal of fluency disorders, 54, 14-23.
[17] Yaruss, J. S., Quesal, R. W., Reeves, L., Molt, L. F., Kluetz, B., Caruso, A. J., McClure, J.A., & Lewis, F. (2002). Speech treatment and support group experiences of people who participate in the National Stuttering Association. Journal of Fluency Disorders, 27(2), 115-134.
[18] Smith, A., & Weber, C. (2016). Childhood stuttering: Where are we and where are we going? Seminars in Speech and Language, 37(04), 291-297.
[19] Yaruss, J. S., & Quesal, R. W. (2006). Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES): Documenting multiple outcomes in stuttering treatment. Journal of fluency disorders, 31(2), 90-115.
[20] Corcoran, J. A., & Stewart, M. (1998). Stories of stuttering: A qualitative analysis of interview narratives. Journal of Fluency Disorders, 23(4), 247-264.
[21] Tetnowski, J. A., & Damico, J. S. (2001). A demonstration of the advantages of qualitative methodologies in stuttering research. Journal of Fluency Disorders, 26(1), 17-42.
[22] Tetnowski, J. A., & Damico, J. S. (2004). Getting out of Procrustes’ bed: The needs and benefits of qualitative research in stuttering. Advances in Speech Language Pathology, 6(3), 153-158.
[23] Connery, A., McCurtin, A., & Robinson, K. (2020). The lived experience of stuttering: a synthesis of qualitative studies with implications for rehabilitation. Disability and rehabilitation, 42(16), 2232-2242.
[24] Atkins, S., Lewin, S., Smith, H., Engel, M., Fretheim, A., & Volmink, J. (2008). Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC medical research methodology, 8(1), 1-10.
[25] Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group*. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Annals of internal medicine, 151(4), 264-269.
[26] Alqhazo, M., Blomgren, M., Roy, N., & Abu Awwad, M. (2017). Discrimination and internalised feelings experienced by people who stutter in Jordan. International journal of speech-language pathology, 19(5), 519-528.
[27] Beilby, J. M., Byrnes, M. L., Meagher, E. L., & Yaruss, J. S. (2013). The impact of stuttering on adults who stutter and their partners. Journal of fluency disorders, 38(1), 14-29.
[28] Bricker-Katz, G., Lincoln, M., & McCabe, P. (2010). Older people who stutter: Barriers to communication and perceptions of treatment needs. International journal of language & communication disorders, 45(1), 15-30.
[29] Bricker-Katz, G., Lincoln, M., & Cumming, S. (2013). Stuttering and work life: An interpretative phenomenological analysis. Journal of fluency disorders, 38(4), 342-355.
[30] Butler, C. (2013). Identity and stammering: negotiating hesitation, side‐stepping repetition, and sometimes avoiding deviation. Sociology of health & illness, 35(7), 1113-1127.
[31] Crichton-Smith, I. (2002). Communicating in the real world: Accounts from people who stammer. Journal of fluency disorders, 27(4), 333-352.
[32] Daniels, D. E., Hagstrom, F., & Gabel, R. M. (2006). A qualitative study of how African American men who stutter attribute meaning to identity and life choices. Journal of fluency disorders, 31(3), 200-215.
[33] Guendouzi, J., & Williams, M. J. (2010). Positioning identity in clinical interviews with people who stutter. Communication & medicine, 7(2), 108-119.
[34] Kathard, H. (2001). Sharing stories: Life history narratives in stuttering research. International journal of language & communication disorders, 36(sup1), 52-57.
[35] Kathard H, Pillay M, Samuel M, Reddy V. (2004) Genesis of self-identity as disother: life histories of people who stutter. South African Journal of Communication Disorders, 51, 4-14.
[36] Kathard, H. (2006). On becoming someone: Self-identity as able. Advances in Speech Language Pathology, 8(2), 79-91.
[37] Kathard, H., Norman, V., & Pillay, M. (2010). Configurations of self-identity formations of adults who stutter. South African Journal of Communication Disorders, 57(1), 51.
[38] Klompas, M., & Ross, E. (2004). Life experiences of people who stutter, and the perceived impact of stuttering on quality of life: Personal accounts of South African individuals. Journal of fluency disorders, 29(4), 275-305.
[39] Perez, H. R., Doig-Acuña, C., & Starrels, J. L. (2015). “Not unless it’sa life or death thing”: a qualitative study of the health care experiences of adults who stutter. Journal of general internal medicine, 30, 1639-1644.
[40] Plexico, L., Manning, W. H., & DiLollo, A. (2005). A phenomenological understanding of successful stuttering management. Journal of fluency disorders, 30(1), 1-22.
[41] Swartz, E., Irani, F., & Gabel, R. (2014). Coping with stuttering. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 24(2), 58-68.
[42] Messenger, M., Onslow, M., Packman, A., & Menzies, R. (2004). Social anxiety in stuttering: measuring negative social expectancies. Journal of fluency disorders, 29(3), 201-212.
[43] Hagstrom, F., & Daniels, D. E. (2004). Social identity and the stuttering experience. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders, 31(Fall), 215-224.
[44] Hayhow, R., Cray, A. M., & Enderby, P. (2002). Stammering and therapy views of people who stammer. Journal of Fluency disorders, 27(1), 1-17.
[45] Sheehan, V., Shanks, P., & Mereu, S. (2005). Easy stuttering: avoidance-reduction therapy. Santa Monica (CA): Sheehan Stuttering Center.
[46] Boyle, M. P. (2013). Psychological characteristics and perceptions of stuttering of adults who stutter with and without support group experience. Journal of fluency disorders, 38(4), 368-381.
![[Corso asincrono] Disortografia: il potenziamento della scrittura. Strumenti pratici.](https://trainingcognitivo.com/wp-content/uploads/2024/06/Disortografia-come-potenziare-la-scrittura-Strumenti-pratici.png)
![[Corso asincrono] Dislessia: come potenziare la lettura. Strumenti pratici.](https://trainingcognitivo.com/wp-content/uploads/2024/06/Dislessia-il-potenziamento-della-lettura.-Strumenti-pratici-1.png)
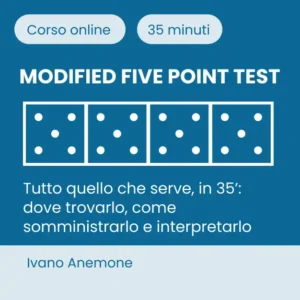
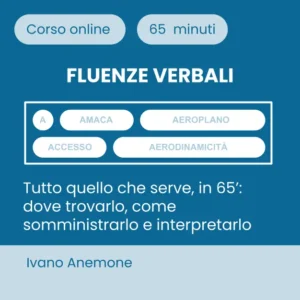

Abbiamo notato che hai iniziato la visita da questo Paese: Svizzera. Riportiamo i prezzi in Franchi Svizzeri per tua comodità. Usa invece questa valuta: Euro. Ignora